Forse nessun Natale come quello appena trascorso ci ha offerto una idea della “festa” completamente scissa, ambigua, rotta al suo interno.
Il riposo in famiglia, i regali, le atmosfere magiche che tradizionalmente associamo alle vacanze di fine anno, ma anche, purtroppo, le manovre coercitive dello Stato in funzione anti-virus, le limitazioni alla libertà, gli ospiti a tavola calmierati, gli spostamenti inibiti anche solo per darsi gli auguri nella casa dei nonni e togliere i fiocchetti a qualche dono.
Il risultato nell’immaginario collettivo, televisivo, letterario? Ai soliti orsacchiotti, elfi e santa Klaus con slitta e renne, abbiamo visto affiancare terrore, lame nel buio, opacità affettive quando non vere e proprie schizofrenie che covano rabbia solitudine e risentimento.
Un must, comunque, delle ricorrenze dove ci si rivede magari intorno a una tavola imbandita, col dovere di rispettare formalmente sorrisi e solidarietà, ma col cuore gonfio di sentimenti spesso intraducibili se non violentemente. Romanzi e film hanno molto frequentemente intercettato questa doppiezza livida e rancorosa, seppur sopita e malcelata, esprimendo al meglio quel concetto di “perturbante” che Freud traduceva col termine “unheimlich”.
Parola dalla semantica bizzarra, che con la particella negativa “un” ben esprime questo clima serpeggiante di smarrimento e sfiducia che pervade gli animi quando si deve fingere benessere e compagnia. Unheimlich, infatti, significa qualcosa di estraneo e spaventevole (heim è la patria, il rifugio), ma anche paradossalmente qualcosa di non segreto, non furtivo, dunque di amichevole (heimlich è sinonimo di clandestino).
Insomma, ciò che ci agghiaccia e con cui rischiamo finanche la nostra incolumità ha il volto del vicino, del parente, del fratello o della moglie, principi e principesse del tradimento e della più classica delle pugnalate alle spalle…
Non stupisce allora che, fra Giallo e Top Crime, noti canali del digitale terrestre, abbiamo visto verso fine dicembre riproporre, per esempio, un episodio dell’Ispettore Barnaby che si intitola non a caso “I fantasmi del Natale”, e più volte la visione di uno dei mistery più inimitabili e carichi di suspense della regina del brivido Agatha Christie, “Il Natale di Poirot”, dove proprio l’immarcescibile investigatore belga con la testa d’uovo, i baffetti impomatati e le ghette alle caviglie esercita le sue celluline grigie su un classico delitto in camera chiusa: vittima, il solito avido e spilorcio avo di una aristocraticissima magione inglese che viene sgozzato sulla sedia a rotelle dopo aver annunciato un cambio di testamento in presenza di figli e nipoti, ciascuno con debiti e pendenze economiche.
Unico particolare: l’ambiente della sua stanza da letto dove è avvenuto il misfatto è perfettamente sigillato dall’interno con chiave girata nella toppa.
Chi l’ha ucciso? Ma, soprattutto: chi è riuscito a commettere l’efferato delitto scappando indisturbato, visto che non ci sono segni di effrazione e vie di fuga? Un gioco di prestigio, una sciarada di sangue e terrore, un rompicapo pazzesco. Una sfida per il creatore classico di assassini, la “locked room”, che ha visto destreggiarsi tutte le più raffinate penne del settore.
Con esiti meravigliosamente cervellotici, sul filo tagliente di una perfetta logica e verosimiglianza, e con una ansia di soluzione che ti attanaglia, sconfiggendoti, fino all’ultimo rigo. In linea con questa tipologia di Cluedo d’inchiostro anche “Il caso dell’abominevole pupazzo di neve” (Giunti) di Nicholas Blake, pseudonimo del poeta Cecil Day-Lewis, padre dell’attore Daniel Day-Lewis, scritto nel 1941, nel pieno cioè della cosiddetta Golden Age dei gialli, là dove la morte diventa quasi un gioco di società fra thè, pettegolezzi, vecchi patriarchi, pipe e salotti damascati.
Stesso clima fascinoso e come sospeso fra disperazione, salvezza e perverso intrattenimento, si vive in “Morte a Linwood Court” (Lindau) di Mary Durham. Anche qui Sir Philip Linwood si candida ad essere la vittima eccellente: baronetto claudicante e acido, spocchioso e aggressivo, proprietario di una vetusta tenuta di campagna, marito di una donna molto più giovane e corteggiata, circondato dall’odio riposto di tanti parenti e conoscenti per i suoi modi spicci e offensivi, viene trovato con la testa spaccata nel vialetto del suo giardino privato.

Qui il fattore “unheimlich” si sprigiona al massimo grado fra una guerra da poco finita che altera il passato e le identità, una morale villana che subito squalifica ogni anelito di vita e creatività, e le solite ottuse convenzioni che obbligano a un conveniente silenzio, a una sacrificata sottomissione ai padroni garanti del lavoro e della sussistenza, a sacche di vendetta che si alimentano giorno per giorno pur nell’addestramento alle buone maniere. Ma soprattutto, le indagini di Scotland Yard porteranno a una sorta di dura resipiscenza della verità che sembra sempre sfuggire – e sempre sfugge – inchiodando il metodo dei detective al martirio della abduzione, ovvero ricominciare sempre daccapo per far combaciare il piano dei fatti e quello quasi onirico delle supposizioni.
Fino all’exploit finale che, in perfetto stile british, fa soccombere ogni deriva di irrazionalità in nome di una super-Ragione che oppone i giusti argini a un Male che arde, invincibile, nell’animo degli uomini. Penetrare nelle pieghe sottili e temibili dell’essere umano, far affiorare le realtà più scomode, giungere al capolinea della ratio intaccata e alla ricomposizione del patto sociale.
Le spy story hanno sempre assolto a questo paradigma: dopo il sangue innocente versato, ritornare alla pax collettiva “ferita” e spiazzata, ai valori traditi, grazie alla sagacia di quella missione inquirente e stabilizzatrice dell’ordo socialis in cui si incarna l’angelo con la pistola, l’ispettore senza macchia e senza paura, l’investigatore privato dalle inimitabili capacità indu-deduttive: profiler ante litteram che, fra sigari e uncinetti, brandy e cimiteri isolati, battono alla grande i moderni camici bianchi alla CSI.
Ma oggi la thriller passion invade i cuori dei lettori proprio con questi scenari che sanno di clinica del diabolico, di profilassi e scientificità assolute, con tutti gli agganci per il trionfo del Bene che giacciono annidati (e annodati) nelle microfibre dei tessuti, nelle goccioline di sangue o saliva, nelle balistiche dei proiettili, nelle analisi psichiatriche dei comportamentisti che appoggiano il commissario di turno.
Una visione rivista e corretta (molto in chiave di business editoriale che va a colpo sicuro) del più classico degli hard-boiled. E così basta mettere nel pentolone alcuni ingredienti cattura-occhio e attenzione - gli 007 con un passato “maledetto” che torna a galla, le full immersion anti-mostro che fanno dimenticare affetti e interessi privati, le tecniche asettiche e mirabolanti della Polizia - e la caccia al serial killer è presto servita. Ma con slittamenti talvolta pericolosi e alquanto opachi a livello di scrittura.
Come in “I segni del male” (Rizzoli) di Simone Regazzoni che parte in ripida salita visto che al decimo rigo già si anticipa che “Sara sarebbe rientrata a casa” se non avesse accettato il passaggio di uno sconosciuto in una sera di tormenta e ghiaccio nella Capitale a Natale.
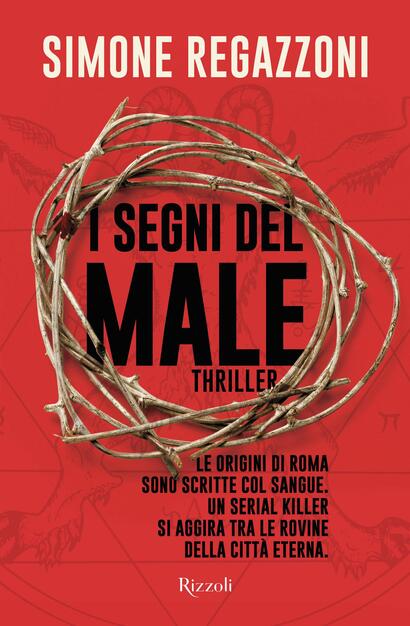
Un vero suicidio letterario che affloscia senza via di uscita l’appeal angoscioso che si sarebbe dovuto invece creare, visto che poi la poverina davvero finisce massacrata e squartata in modo impietoso nelle grinfie di quello che si annuncia come il demone di una trama esoterica che lascia, in pieno freddo dicembrino, molti cadaveri orrendamente mutilati sulle vie e negli anfratti più insondabili della Città Eterna.
Se a questo si aggiunge l’uso stereotipato e senza sfumature semantiche di termini come “surreale”, “oscurità” e “mostruoso”, una certa astuzia nello sviluppo delle vicende narrate che però rivelano debolezze anticipatrici già a metà libro, e un vortice psicotico finale che sa di sbrigativo e poco credibile, beh allora siamo di fronte alla dimostrazione che il gioco dell’inquietante e spaesante “unheimlich” non vive di una besciamella fredda sparsa sulle emorragie di una storia di sventure e ammazzamenti, ma di una julienne ben tagliuzzata di spasmi, tensioni e correnti alternate che non è proprio da tutti saper preparare nel tepidarium dell’Inconoscibile.
Per fortuna ci pensa Soren Sveistrup in “L’uomo delle castagne” (Rizzoli) a recuperare quel tremore millesimato che non deve essere per forza grandguignolesco e grottesco, ma appuntito come un bisturi quanto basta per far percepire l’ingresso del patologico nella normalità, l’informe unione di una natura ria e di una metropoli infingarda, lo spossessamento delle certezze, l’arte sottile delle trepidazioni e dei traguardi falliti, e comunque sempre quel disastro esistenziale che unisce il carnefice e la preda, il lupo da inseguire e gli stivaloni dei gendarmi, tutti colpi di pennello, tutti schizzi al vetriolo di un unico affresco che puzza ovunque del lercio del limite e della libertà. E non a caso in questo certi scrittori del Nord Europa hanno fatto scuola negli ultimi anni. Ed è tutto un altro leggere dipendendo come una droga dalla parola “fine”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News




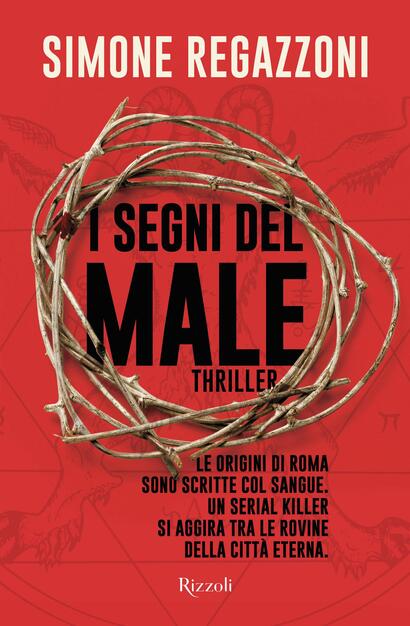

 APPUNTAMENTI IN AGENDA
APPUNTAMENTI IN AGENDA