
Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
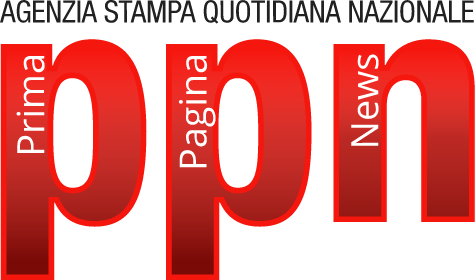
"Si è passati da 20,6 confezioni per 1000 bambini (prevalenza pari allo 0,26%) nel 2016 a 59,3 confezioni per 1000 bambini (prevalenza dello 0,57%) nel 2024".

"Si è passati da 20,6 confezioni per 1000 bambini (prevalenza pari allo 0,26%) nel 2016 a 59,3 confezioni per 1000 bambini (prevalenza dello 0,57%) nel 2024".
Stabili i consumi: quasi 2 dosi al giorno a testa nel 2024. Cresce la spesa farmaceutica complessiva (+2,8%), trainata dall’aumento della spesa pubblica (+7,7%) a fronte di un numero crescente di terapie innovative e ad alto costo rimborsate dal SSN.
I cittadini spendono di più per medicinali senza ricetta (SOP e OTC) e non rinunciano al farmaco di marca, specie al Sud. Si conferma una notevole variabilità regionale, in termini di consumi, spesa, aderenza e appropriatezza.
Sono alcuni punti chiave del Rapporto OsMed 2024 sull’uso dei medicinali in Italia, realizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e pubblicato sul portale istituzionale.
Nel 2024 la spesa farmaceutica totale è stata pari a 37,2 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2023), di cui il 72% rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La spesa farmaceutica pubblica si è attestata infatti sui 26,8 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2023 (+7,7%).
La spesa territoriale pubblica, comprensiva di quella convenzionata e in distribuzione diretta e per conto, è stata di 13 miliardi e 700 milioni, con un aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente, determinato, anche quest’anno, dall’incremento della spesa dei farmaci di classe A erogati in distribuzione diretta (+4,6%) e per conto (+10,9%).
La spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche è stata di circa 17,8 miliardi di euro (301,8 euro pro capite) e ha registrato un incremento del 10% rispetto al 2023, a fronte di un aumento dei consumi (+4,7%) e del costo medio per giornate di terapia (+4,8%).
La spesa a carico dei cittadini, comprendente la spesa per compartecipazione (ticket regionali e differenza tra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto erogato al paziente e il prezzo di riferimento), per i medicinali di classe A acquistati privatamente e quella per i farmaci di classe C, ha raggiunto un valore di 10,2 miliardi di euro nel 2024.
Dal confronto con 9 Paesi europei (Germania, Belgio, Austria, Spagna, Francia, Svezia, Portogallo, Gran Bretagna e Polonia), la spesa farmaceutica totale italiana – comprensiva della spesa territoriale pubblica e privata e dell’ospedaliera – con un valore di 672 euro pro capite, è inferiore rispetto a quella registrata in Germania (742 euro), Austria (733 euro) e Belgio (681 euro), mentre è ben al di sopra dei valori di Portogallo (481 euro), Svezia (488 euro), Gran Bretagna (541 euro) e della media dei Paesi europei, pari a 418 euro.
Tuttavia, se si considerano le diverse forme di pay-back vigenti in Italia, tra i quali quello di ripiano dello sfondamento del tetto degli acquisti diretti, non presenti in altri Paesi europei, la spesa pro capite dell’Italia scende a 627 euro pro capite. Tale valore si colloca al di sotto della spesa di Francia e Spagna, in linea con la spesa media dell’Europa a 10 Paesi.
Per quanto riguarda i prezzi dei farmaci, se si considera il mercato complessivo, comprensivo dei farmaci erogati sia in ambito territoriale che ospedaliero, l’Italia ha prezzi inferiori a Belgio (+75,8%), Germania (+51,9%), Austria (+42,0%), Svezia (+29,5%), Gran Bretagna (+4,2%), Spagna (+3,5%), mentre in Francia (‐10,6%), Polonia (‐30,4%) e Portogallo (‐37,6%) si registrano prezzi più bassi, ma sono Paesi nei quali c’è una disponibilità di prodotti anche molto inferiore rispetto a quelli accessibili in Italia.
I prezzi medi europei sono superiori del 62,5% rispetto a quelli applicati in Italia. Nel 2024 in Italia sono state consumate 1.895 dosi di medicinali ogni 1000 abitanti al giorno, ovvero ogni cittadino, inclusi i bambini, ha assunto circa 1,9 dosi di farmaco. Il 70,8% è erogato a carico del SSN e il restante 29,2% è acquistato privatamente.
Per quanto riguarda l’assistenza territoriale pubblica e privata, sono state dispensate quasi 2 miliardi di confezioni, in leggera diminuzione rispetto al 2023.
Tra i farmaci rimborsati dal SSN, i medicinali per il sistema cardiovascolare si confermano al primo posto per consumi (523 dosi giornaliere per 1000 abitanti) e al secondo per spesa (3,7 miliardi di euro) dietro agli antitumorali e immunomodulatori (circa 8,2 miliardi di euro). Al secondo posto per consumi si collocano i farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo (296 dosi giornaliere per 1000 abitanti), che sono la terza categoria in termini di spesa (3 miliardi e 495 milioni di euro), con una spesa pro capite SSN pari a 59,3 euro, in aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente.
I farmaci del sangue e organi emopoietici occupano il terzo posto in termini di consumi (145,2 dosi giornaliere per 1000 abitanti) e il quinto in termini di spesa (2 miliardi e 647 milioni di euro). I farmaci del sistema nervoso centrale si posizionano al quarto posto per consumi (99,8 dosi giornaliere per 1.000 abitanti) e al sesto in termini di spesa (2 miliardi e 148 milioni di euro).
Complessivamente, nel 2024 il 68% degli assistiti ha ricevuto almeno una prescrizione di farmaci, le donne (72,1%) più degli uomini (63,6%). Le differenze di sesso sono più marcate nella fascia di età tra i 20 e i 59 anni, in cui le donne hanno più prescrizioni di antibiotici (utilizzati per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie), antianemici e farmaci del sistema nervoso centrale, in particolare antidepressivi. prescrizione farmaceutica, pari al 50,9% della popolazione pediatrica italiana, con una prevalenza leggermente superiore nei maschi rispetto alle femmine (51,9% contro 49,9%).
Gli antinfettivi per uso sistemico si confermano la categoria terapeutica a maggiore consumo in età pediatrica, seguiti dai farmaci dell’apparato respiratorio e dai preparati ormonali sistemici, esclusi quelli sessuali e insuline; per tutte le categorie si osserva un incremento dei consumi rispetto all’anno precedente.
I farmaci del sistema nervoso centrale (antiepilettici, antipsicotici, antidepressivi e psicostimolanti) sono al quarto posto tra i medicinali più prescritti, con un consumo pari all’8% del totale e un aumento del 4,1% rispetto al 2023. Dal 2016 sono più che raddoppiati sia la prevalenza d’uso che i consumi di psicofarmaci. Sebbene si mantengano ancora su livelli bassi, si è passati da 20,6 confezioni per 1000 bambini (prevalenza pari allo 0,26%) nel 2016 a 59,3 confezioni per 1000 bambini (prevalenza dello 0,57%) nel 2024. Si tratta soprattutto di antipsicotici, antidepressivi e farmaci per l’ADHD.
Il ricorso agli psicofarmaci presenta un andamento crescente per età, raggiungendo il massimo nella fascia 12‐17 anni, nella quale si registra un consumo di 129,1 confezioni per 1000 e una prevalenza dell’1,17%. Un trend in crescita, in linea con i risultati di altri studi epidemiologici internazionali pubblicati, che evidenziano una generale tendenza all’aumento dei tassi di prescrizione di questi medicinali in tutti i Paesi del mondo, soprattutto in seguito alla pandemia di COVID‐19.
In Italia, nonostante l’aumento osservato negli ultimi anni, in parte legato alle conseguenze dell’emergenza pandemica sulla salute mentale di bambini e adolescenti, l’uso dei farmaci psicotropi rimane sensibilmente più basso rispetto ad altri Paesi.
Nel 2024 la prescrizione di questi medicinali nella popolazione pediatrica italiana si attesta allo 0,57%, un dato sì raddoppiato rispetto al 2020 (0,30%), ma ancora inferiore rispetto ad altri Paesi europei (ad esempio la Francia con 1,61%) ed extra‐europei (USA 24,7%‐26,3%). Anche per il 2024 il Rapporto conferma un trend di spesa e consumi crescente con l’età.
Nella popolazione anziana la spesa media per utilizzatore ammonta a 570,2 euro (621,6 nei maschi e 529,5 nelle femmine), in lieve aumento rispetto al 2023 (+1,2%). Ben il 97,4% degli anziani ha ricevuto nel corso dell’anno almeno una prescrizione farmacologica. In media si arriva a oltre 3,4 dosi al giorno, gli uomini ne prendono più delle donne. Per entrambi i sessi, all’aumentare dell’età si assiste a un progressivo incremento del numero di principi attivi assunti.
Il 68,1% degli over 65 ha ricevuto prescrizioni di almeno 5 diverse sostanze (politerapia) nel corso del 2024 e circa uno su tre (28,3%) ha assunto almeno 10 principi attivi diversi. Inoltre, dal Rapporto emerge che il 33,1% della popolazione anziana (3 pazienti su 10) assume almeno 5 differenti farmaci per almeno 6 mesi nel corso di un anno (politerapia cronica), con un andamento crescente all’aumentare dell’età: fra gli 85 e gli 89 anni si raggiunge il picco del 43,7%, quasi uno su due.
Più farmaci, più dosi, più occasioni di errore e di abbandono: seguire bene la cura, per il tempo necessario, diventa difficile. La scarsa aderenza del paziente alle prescrizioni del medico è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche. Nel caso di terapie croniche, inadeguati livelli di aderenza e persistenza al trattamento sono associati a un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, morbilità e mortalità, rappresentando un danno sia per il paziente che per il Servizio Sanitario Nazionale.
La popolazione anziana è quella più a rischio. Ma l’aderenza alla cura varia anche a seconda della categoria terapeutica: maggiori criticità si osservano con i farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie (52,2% pazienti con bassa aderenza), gli antidepressivi (28,1%, con la conseguenza di una cronicizzazione della malattia) e i farmaci antidiabetici (22,6%, in calo del 5% rispetto all’anno precedente).
Minori criticità si osservano con i farmaci per il trattamento dell’osteoporosi (68,7% pazienti con alta aderenza) seguiti dalla terapia per l’ipertrofia prostatica benigna (64,9%), dagli antiaggreganti (61,8%), anticoagulanti (53,2%) e antipertensivi (52,6%). Per i farmaci lipolipemizzanti l’alta aderenza è pari al 45,6% dei pazienti in trattamento: il dato è in aumento dal 2019 (+4% rispetto al 2023), ma ci sono ancora margini di miglioramento anche per questi medicinali.
Per quasi tutte le categorie terapeutiche analizzate poco più della metà dei pazienti era ancora in trattamento dopo 12 mesi, con valori massimi per gli anticoagulanti (66,6%), mentre per i farmaci per asma e BPCO si registra il 50% di probabilità di interrompere la terapia dopo appena 36 giorni.
Tendenzialmente le donne sono meno aderenti e persistenti degli uomini per tutte le categorie terapeutiche analizzate e le Regioni del Sud registrano livelli di aderenza e persistenza al trattamento più bassi rispetto al resto d’Italia.
Nel 2024 gli antidiabetici hanno registrato una spesa pubblica complessiva di 1 miliardo e 642 milioni di euro, con un aumento del 13,2% rispetto al 2023. Sono infatti aumentati sia i consumi (+4,3%) sia il costo medio per dose (+8,3%), con uno spostamento dei consumi verso categorie di farmaci di più recente introduzione in terapia, come gli analoghi del GLP‐1, le gliflozine e le loro associazioni. In particolare, gli analoghi del Glp-1, a cui appartiene la semaglutide, nonostante una riduzione del costo medio pari all’1,8%, registrano un aumento di spesa dell’11,5% e dei consumi del 13,3%, con la sola semaglutide che cresce rispettivamente del 58,4% e del 59,8%. Nel 2024 sono la categoria, da sola o in associazione alle insuline, che registra il costo annuale per utilizzatore più elevato (722,5 euro per gli analoghi del GLP‐1 da soli e 736,1 in associazione alle insuline).
Le gliptine da sole registrano un aumento di spesa (+35,5%) attribuibile esclusivamente all’incremento del costo medio per giornata di terapia (+40,3%), considerando la contrazione del 3,7% dei consumi. Infine, per le gliflozine da sole si rileva un aumento di spesa del 39,6% e dei consumi del 45,1% (ma una riduzione del costo medio per giornata di terapia del 4,1%).
La metformina, quando usata da sola, è ancora il farmaco più utilizzato nel trattamento del diabete (23,4 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti), pari al 31,5% del totale, mentre i nuovi farmaci agonisti dei recettori GIP e GLP‐1, rappresentati dalla tirzepatide, sono la categoria a maggior costo medio per giornata di terapia con un valore di 130,57 euro.
Resta ancora elevato il consumo di antibiotici in Italia, sebbene il 2024 abbia mostrato un lieve calo rispetto al 2023 (‐1,3%), attestandosi a 16,9 dosi giornaliere ogni mille abitanti. Quasi 4 persone su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotico nel 2024, con una prevalenza d’uso più elevata nei bambini fino a 4 anni di età (45‐47%) e negli over 85 (54‐58%). L’amoxicillina+acido clavulanico, antibiotico ad ampio spettro ampiamente impiegato in ambito pediatrico, si conferma la molecola a maggior utilizzo con 6,4 dosi giornaliere ogni mille abitanti (pari al 38% dell’intera categoria) e a maggiore spesa (3,13 euro pro capite), seguito per consumi dalla claritromicina (1,9 dosi giornaliere per mille abitanti) e dall’azitromicina (1,6 dosi giornaliere per mille abitanti).
Livelli più elevati nell’utilizzo di antibiotici si registrano ancora al Sud, dove il 43,6% della popolazione ne ha assunto almeno uno in corso d’anno, contro il 40,1% del Centro e il 30,6% del Nord. In generale, le Regioni del Sud e Isole, pur mostrando nel confronto con il 2023 una riduzione del consumo del 5,1%, presentano non solo una maggiore prevalenza d’uso e un maggiore consumo di antibiotici, ma anche un costo più elevato per singolo utilizzatore rispetto al Nord e al Centro. Differenze che fanno riflettere anche su prescrizioni e consumi non sempre appropriati.
“I dati di prevalenza d’uso – si legge nel Rapporto – evidenziano la necessità di potenziare i programmi di ‘Antimicrobial Stewardship’ (gestione antimicrobica), specialmente nelle popolazioni con la prevalenza d’uso più alta, per ottimizzare il consumo e ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza”.
Gli equivalenti hanno rappresentato nel 2024 il 23,5% della spesa e il 31,6% dei consumi, con un trend di crescita che negli ultimi 5 anni è stato costante ma tuttavia limitato. Il consumo di generici in Italia resta infatti basso, soprattutto se confrontato con quello di altri Paesi europei, collocando l’Italia al terz’ultimo posto in Europa, con una percentuale del 56% di equivalenti sul consumo territoriale. Eppure l’uso degli equivalenti consente risparmi significativi sia per il Servizio Sanitario Nazionale che per il cittadino.
Tra il 2017 e il 2024 l’analisi condotta da AIFA su 10 principi attivi ha stimato un risparmio per il SSN di circa 5,3 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro solo nel 2024) sulla spesa per i farmaci di classe A rimborsati dal SSN, a seguito dell’ingresso dei farmaci equivalenti nelle liste di trasparenza AIFA. I principi attivi che hanno generato i risparmi maggiori sono stati la rosuvastatina e l’associazione ezetimibe/simvastatina.
Ammonta inoltre a circa 1 miliardo di euro la spesa di compartecipazione sostenuta dai cittadini come differenza tra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto e il prezzo dell’equivalente rimborsato. Un dato stabile rispetto al 2023, con una spesa pro capite che va da 22,4 euro al Sud e nelle Isole a 14,2 euro al Nord. Come evidenzia un’analisi di correlazione tra la spesa per compartecipazione e il reddito pro capite regionale, sono proprio le Regioni a più basso reddito quelle in cui si spende di più per avere il farmaco di marca a brevetto scaduto (in particolare Calabria, Sicilia e Campania).
Si conferma inoltre una profonda eterogeneità regionale nell’uso dei farmaci equivalenti. Il Nord consuma la percentuale maggiore di generici (45,5%) rispetto al Centro (34,2%) e al Sud e Isole (25,3%). Al contrario, nelle Regioni del Sud e Isole prevale nettamente il consumo del farmaco ex originator (75% della quota a brevetto scaduto), che costa di più, facendo lievitare la spesa pro capite per i farmaci a brevetto scaduto nel complesso. Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia mostrano un minor ricorso agli equivalenti (19‐22%), contrariamente alla Provincia Autonoma di Trento e alla Lombardia per le quali si registrano i valori più alti (45% e 44% rispettivamente).
In controtendenza rispetto agli equivalenti, l’Italia è invece al primo posto nell’incidenza della spesa (59,8%) e del consumo (72,2%) di farmaci biosimilari rispetto alla media europea. La spesa privata complessiva (comprensiva di compartecipazione, acquisto privato di classe A, classe C con ricetta e SOP/OTC) è stata di 10,2 miliardi di euro nel 2024.
Tra i farmaci di fascia A acquistati privatamente dai cittadini nel 2024 con una spesa di 1,6 miliardi di euro, colecalciferolo, amoxicillina/acido clavulanico e ibuprofene si collocano di nuovo ai primi tre posti, con un aumento di spesa del 4,5% per il colecalciferolo, una riduzione del 7,8% dell’associazione amoxicillina/acido clavulanico e una sostanziale stabilità (+0,1%) per l’ibuprofene. I medicinali dell’apparato gastrointestinale risultano comunque i più utilizzati tra le prime 20 categorie di farmaci di classe A acquistati privatamente (81,8 dosi giornaliere ogni mille abitanti, pari al 37,5% del totale).
La spesa per i farmaci di Classe C (interamente a carico del cittadino) nel 2024 supera i 7 miliardi di euro, con un lieve decremento dell’1,96% rispetto al 2023. Il 52% è relativo a farmaci con obbligo di prescrizione medica (3,7 miliardi di euro), e il restante 48% a farmaci di automedicazione (3,4 miliardi).
I farmaci di classe C con ricetta registrano una riduzione della spesa pari al 4,9% rispetto al 2023, determinata da una riduzione della quantità (‐2,8%) e dei prezzi (‐1,1%). Le categorie di farmaci di classe C con ricetta maggiormente acquistati dai cittadini nel 2024 si confermano essere le benzodiazepine (ansiolitici, 371 milioni di euro), gli analgesici e gli antipiretici e i farmaci per la disfunzione erettile.
Per questi ultimi nel 2024 sono stati spesi circa 245 milioni di euro. Particolarmente importante risulta l’incremento di spesa privata degli analoghi del recettore GLP-1 utilizzati per perdere peso, per lo più attribuibile ad un corrispettivo aumento dei consumi (+78,7%) nel 2024.
Nella classifica dei primi 30 principi a maggiore spesa nel 2024 entra la semagutide, non presente nell’anno precedente, con una spesa di 55,3 milioni di euro, a cui si aggiungono 21,8 milioni di acquisto privato di fascia A. Tra i farmaci di automedicazione, i derivati dell’acido propionico (FANS) rappresentano l’11,5% della spesa complessiva con un valore di 384,7 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2023.
I primi principi attivi per spesa si confermano ibuprofene e diclofenac, che mostrano rispettivamente una leggera riduzione (‐0,6%) e un consistente aumento (+6,4%). Il numero di terapie avanzate autorizzate in Italia è aumentato progressivamente negli anni, passando da due nel 2019 a un totale di 12 terapie rimborsate nel 2024. Di queste 11 sono quelle commercializzate nel periodo 2019‐2024 (5 CAR‐T, 4 terapie geniche in vivo, una terapia genica ex vivo e un prodotto di ingegneria tissutale), per un totale di 17 indicazioni rimborsate, oltre la metà in campo onco‐ematologico. Parallelamente sono aumentati anche i valori di spesa e consumo; la prima è passata da un totale di 1,38 milioni di euro nel 2019 (pari allo 0,01% della spesa totale per gli acquisti diretti) a un valore di 194,48 milioni nel 2024 (con una incidenza di circa l’1,2% sulla spesa per acquisti diretti), in aumento del 60,2% rispetto al 2023.
Anche i consumi sono aumentati, passando dalle 14 confezioni erogate nel 2019 alle 1.016 confezioni del 2024, più del doppio rispetto all’anno precedente.
Cresce nel 2024 anche la spesa per i farmaci orfani, comprensiva dell’acquisto da parte delle strutture sanitarie pubbliche e dell’erogazione in regime di assistenza convenzionata, con un incremento del 5,9% rispetto al 2023, attestandosi a 2,36 miliardi di euro, corrispondente all’8,3% della spesa farmaceutica a carico del SSN.
La prima categoria terapeutica per spesa e consumi è quella dei farmaci antineoplastici e immunomodulatori (rispettivamente 47,3% e 49,6%). La più alta incidenza di consumi e spesa riguarda nello specifico i farmaci utilizzati nei linfomi, mielomi e altre malattie onco‐ematologiche e nelle malattie genetiche, riconfermando lo stesso andamento dello scorso anno.
Nel triennio 2022‐2024, un totale di 46 farmaci ha beneficiato del requisito di innovatività piena per almeno un’indicazione terapeutica, più della metà dei quali è rappresentata da farmaci antineoplastici o orfani, mentre 7 sono terapie avanzate.
Nel 2024 la spesa per questi farmaci ha raggiunto 868 milioni di euro, corrispondente al 5,2% della spesa delle strutture pubbliche per le sole indicazioni innovative dei farmaci di classe A e H. Una quota significativa di questa spesa (circa 400 milioni di euro) riguarda medicinali ed indicazioni terapeutiche che nel corso del 2024 hanno perso il requisito dell’innovatività. Il riconoscimento dell’innovatività comporta l’immediata accessibilità del farmaco per gli assistiti, anche senza l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali, e l’accesso al Fondo dedicato, che per il 2024 ammontava a 1 miliardo e 300 milioni. Pertanto, rispetto alle risorse disponibili, la spesa ha fatto registrare un avanzo di 432 milioni di euro.
“Il Rapporto OsMed, strumento fondamentale per orientare le politiche sanitarie e garantire una gestione consapevole e sostenibile delle risorse – afferma il Presidente di AIFA, Robert Nisticò – evidenzia nel 2024 l’impegno sull’innovazione terapeutica e la tutela della salute pubblica, in un contesto di crescenti sfide economiche e sociali. Si colgono segnali positivi, come l’aumento del numero di terapie avanzate e farmaci per le malattie rare rimborsati dal SSN e i risparmi generati in seguito all’ingresso degli equivalenti nelle liste di trasparenza AIFA. Ma c’è ancora da migliorare. L’aumento delle prescrizioni di psicofarmaci fra i più giovani sottolinea quanto sia prioritaria la tutela della salute mentale di bambini e adolescenti. È fondamentale continuare a promuovere il consumo dei generici, in crescita costante ma ancora limitato, l’aderenza alle terapie, l’appropriatezza prescrittiva e l’uso ottimale delle risorse disponibili, per garantire l’innovazione e le migliori opportunità di cura ai pazienti nel rispetto della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per raggiungere questi obiettivi sono essenziali il dialogo e la collaborazione con le Regioni, con l’intento comune di utilizzare al meglio le risorse e assicurare una maggiore equità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale”.
“Il Rapporto OsMed ogni anno fornisce un quadro complessivo sull’uso dei farmaci in Italia – sottolinea il Direttore tecnico‐scientifico Pierluigi Russo – con alcune novità a fronte di tendenze che invece ricorrono ogni anno, come quella dell’ampia variabilità regionale. Nonostante gli spazi di miglioramento che in diversi ambiti terapeutici sarebbe possibile colmare, la spesa pro capite italiana è sostanzialmente in linea con quella media europea, inferiore a quella di Germania, Francia, Spagna e di altri Paesi europei; e i prezzi sono molto più bassi rispetto a quelli medi europei. Ambiti di rilevante attenzione sono i nuovi antidiabetici, efficaci anche nella riduzione del peso, gli psicofarmaci in età pediatrica, le terapie avanzate (geniche e cellulari) e i farmaci orfani per il trattamento di malattie rare”.