
Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
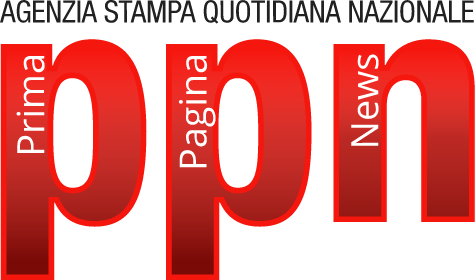
Secondo la norma, prima ancora di approfondire la fattibilità tecnico-economica, l'amministrazione deve accertare l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale.

Secondo la norma, prima ancora di approfondire la fattibilità tecnico-economica, l'amministrazione deve accertare l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale.
Nel momento in cui un operatore economico presenta una proposta di partenariato pubblico-privato, qual è la prima mossa che l'amministrazione deve fare? Cosa vuol dire verificare l’“interesse pubblico” previsto dal Codice dei contratti? Basta una valutazione dell'ufficio tecnico, o servono competenze più articolate? E bisogna formalizzare la decisione con atto proprio, oppure no?
A chiarire come applicare correttamente l'istituto è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere del 19 novembre 2025, n. 3824, che dà una lettura puntuale della ratio dell'art. 193, comma 4, del nuovo Codice Appalti (d.Lgs. n. 36/2023).
Il quesito posto al Supporto Giuridico è incentrato sull'esatto significato della verifica preliminare dell'interesse pubblico nelle proposte di project financing su iniziativa del promotore privato.
Secondo quanto stabilisce la norma, prima ancora di approfondire la fattibilità tecnico-economica, l'amministrazione ha il dovere di accertare l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale. Si tratta di un passaggio all'apparenza preliminare, ma in realtà decisivo, perché permette di selezionare le iniziative davvero utili e coerenti con la programmazione dell’ente, in modo da evitare che progetti privi di adeguata utilità collettiva impegnino risorse amministrative per istruttorie lunghe e costose.
Con il nuovo Codice, il legislatore ha chiarito che il partenariato pubblico-privato non può essere una scorciatoia per interventi assenti nelle strategie dell’amministrazione. Dunque, la proposta va valutata tenendo conto dei bisogni del territorio, degli strumenti programmatori (DUP, programmazione triennale) e degli obiettivi dell’ente.
Si tratta di un controllo di coerenza strategica e tecnica.
Questa verifica, chiarisce il Mit, non coincide con la valutazione di fattibilità, ma ha una funzione autonoma e distinta, dato che funge da filtro sull’allineamento tra proposta e indirizzi dell’amministrazione. E' un'attività da svolgere in modo trasparente e motivato, che termina con un provvedimento espresso, solitamente adottato dalla dirigenza tecnica, e che non ha una natura formale, perché è il primo passo di una scelta programmatoria.
Per il supporto giuridico, l'obiettivo della verifica è quello di valutare l'utilità e la coerenza della proposta rispetto ai bisogni collettivi dell’ente. Non è una mini-fattibilità, né anticipa l’analisi del Pef, ma è utile a capire se l'idea proposta meriti di essere istruita più approfonditamente. L'amministrazione deve anche tenere conto della capacità della proposta di rispondere a fabbisogni pubblici reali, della compatibilità con la programmazione vigente e dell'assenza di ostacoli dal punto di vista giuridico-amministrativo.
Nel caso si tratti di progetti più impegnativi, è opportuno analizzare anche la complessità tecnologica, gli aspetti gestionali e la sostenibilità nel tempo. In questa fase, più che la fattibilità tecnica, si misura la “ragionevolezza pubblica” dell’iniziativa, cioè la sua capacità di diventare un tassello coerente delle politiche d'investimento dell'ente.
Uno degli aspetti più importanti chiariti dal Mit è quello sulle competenze necessarie: sicuramente, l'ente può svolgere la verifica in autonomia, ma questo non vuol dire che una singola nota dell'ufficio tecnico sia sufficiente. Il partenariato è una materia multidisciplinare, per cui sono richieste competenze giuridiche, tecniche, economico-finanziarie e gestionali.
Per i progetti complessi o che hanno un'importante rilevanza economica, il Ministero suggerisce di coinvolgere professionalità specialistiche, interne o esterne. A titolo di esempio, l'analisi costi-benefici è un passaggio fondamentale, da affrontare con criteri oggettivi, trasparenti e metodologicamente fondati.
A predisporre l'istruttoria è il responsabile del procedimento, come vuole la legge n. 241/1990, mentre la decisione conclusiva, di regola, fa capo alla dirigenza tecnica, a ulteriore conferma della natura sostanziale del procedimento.
Il Mit conclude precisando che la verifica dell'interesse pubblico finisce sempre con un atto amministrativo espresso, motivato e pubblicato. Non è una mera fase istruttoria o un appunto interno, ma un provvedimento autonomo, con responsabilità ed effetti propri. Si tratta del momento in cui l'amministrazione assume, in via ufficiale, la decisione di procedere o meno alla fase successiva, cioè con la valutazione di fattibilità tecnico-economica e con l'eventuale inserimento in programmazione.
 APPUNTAMENTI IN AGENDA
APPUNTAMENTI IN AGENDA