
Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
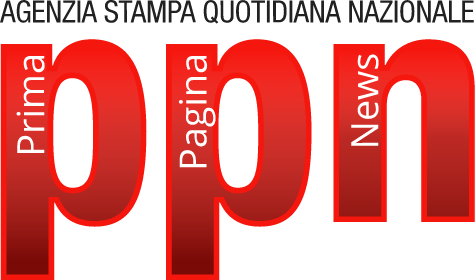
Il bianco e nero del film ci restituisce la duplicità della morale.

Il bianco e nero del film ci restituisce la duplicità della morale.
Era una scommessa per Ozon portare sullo schermo il famoso romanzo del 19432 di Albert Camus. L’esito è molto positivo.
Dopo l’altra esperienza del 1967 di Luchino Visconti con Marcello Mastroianni protagonista, il regista francese ha voluto differenziarsi da essa ampliando il registro interpretativo, non limitandosi a seguire in maniera pedissequa il romanzo originale. L’utilizzo del bianco e nero è assoluto e parte già dai titoli di testa , continua con l’utilizzo di filmati d’epoca, per inquadrare storicamente l’azione, e prosegue fino alla fine del film. Bianco e nero, arabi e francesi, morale comune e morale personale.
Dicotomie sulle quali si innesta il racconto del giovane impiegato francese che vive ad Algeri Meursault, raggiunto dalla notizia della morte della madre, si reca nel paese dove si trova la residenza sociale dove l’ha ricoverata quando non ha potuto più far fronte alla sua assistenza. Non mostra commozione al funerale e quando avrà grandi conseguenze negative successivamente.
Tornato ad Algeri si reca al mare e qui incontra una ex collega, Marie, con la quale inizia una relazione amorosa. Une serie di casi lo porterà poi ad uccidere un giovane arabo, intenzionato a difendere l’onore della sorella, offeso dal vicino di Meursault. Il giovane non negherà mai l’accaduto e come si siano svolti i fatti, Ozon gli fa rivendicare la libertà della sua azione, a cui si è sentito costretto dalle circostanze.
La visione nichilista si scontra con la morale imperante che lo giudica non tanto per l’assassinio ma per il suo comportamento successivamente alla morte della madre: non aver pianto o mostrato alcun dolore per la perdita, a differenza dell’anziano fidanzato della defunta; aver cominciato un rapporto con una ragazza il giorno dopo del funerale. Queste sono le colpe che lo condurranno alla ghigliottina.
Il bianco e il nero, il rapporto tra francesi, dominatori, e arabi, colonizzati, e Ozon compie un altro scarto rispetto al romanzo originale: dà un nome al giovane arabo ucciso, mostrandone la tomba. Invece, fedelmente allo scritto, rende sullo schermo la sorta di estraneità con la quale scorre la vita del protagonista, il suo rispondere a sillabe ad ogni domanda che gli ponga sia sul matrimonio che sul lavoro, tanto da utilizzare in voice over la voce dello stesso Camus per descrivere alcune parti del film, fondendo la forza letteraria della parola con la forza delle immagini del cinema. La realizzazione del film non ha tralasciato l’aspetto sonoro.
La colonna è sospesa tra tradizione orientale e linguaggio elettronico fino all’utilizzo del brano dei Cure sui titoli di coda: Killing an arab, piccolo poema punk ispirato al romanzo di Camus.
(Alfredo Salomone)