
Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
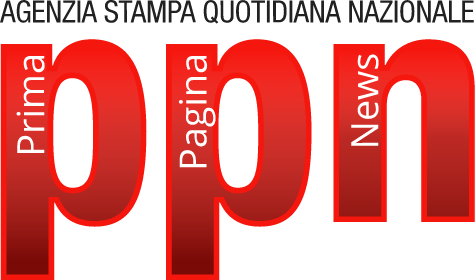

Lo chiamarono “l’altro dopoguerra”, il periodo vissuto nell’Italia meridionale e a Roma, tra il luglio 1943, dopo lo sbarco Alleato in Sicilia, e il maggio 1945, quando la guerra finisce.
E’ il periodo in cui, nel Mezzogiorno, inizia - accettata con entusiasmo o obbligata - la convivenza con i liberatori anglo-americani, mentre al centro-nord continua l’occupazione tedesca e si intensifica la lotta di liberazione. Questa pagina di storia “dell’altro dopoguerra del Mezzogiorno” - ad eccezione delle Quattro giornate di Napoli, durante le quali dal 27 al 30 settembre 1943 i napoletani insorsero e con coraggio cacciarono via i soldati del Reich - non ha mai trovato lo spazio che meritava nella storiografia ufficiale e nella memoria degli italiani.
Il silenzio storiografico, ha oscurato il contributo, rilevante, del Mezzogiorno alla guerra di Liberazione: con le sue rivolte popolari, la costituzione delle bande di partigiani e i numerosi casi di resistenza individuale. C’è, invece, un filo rosso che lega gli episodi di lotta ai tedeschi al Sud, col Nord dei partigiani, tanto da rappresentare, “questo Mezzogiorno”, un vero laboratorio per la Resistenza italiana.
In più, come viene fuori in ritardo, dagli archivi e dalle ricerche, sono stati migliaia i meridionali che militarono nella bande partigiane sulle Alpi e sugli Appennini, o all’estero o perché immigrati nel Centro Nord o perché militari di stanza in territori fuori dell’Italia liberata.
Non aver accomunato il movimento partigiano del Nord, agli episodi di resistenza spontanea al Sud, è un buco nero nella storiografia ufficiale: un errore, ammesso a distanza di anni, da Vittorio Foa, uno degli uomini simbolo della Resistenza italiana: “Io, da nordista, pensavo che nell’esperienza settentrionale ci fossero dei valori specifici superiori. Era una stupidaggine”.
Questa lacuna storiografica sull’altro dopoguerra meridionale, la colma ora un libro ben scritto e rigorosamente documentato: “Paisà, Sciuscià e Segnorine”, autori Mario Avagliano e Marco Palmieri (il Mulino, pagine 503, euro 26).
E’ un saggio storico che ricompone il lungo racconto corale di quell’Italia che per prima si affacciò al dopoguerra, con lo sbarco in Sicilia (il 10 luglio 1943) delle truppe alleate salpate dall’Africa settentrionale e da Malta e successivamente con la risalita dello stivale italico.
Pochi giorni dopo lo sbarco in Sicilia, il 25 luglio, ci sarebbe stata la caduta di Mussolini.
Il percorso di uscita dalla guerra, dell’Italia, cominciò da Sud, con un dopoguerra diverso dal Nord e poco raccontato. Dal punto di vista sociale, il dopoguerra anticipato, del Sud e di Roma, costituisce anche un primo assaggio di quell’american way of life che si sarebbe poi affermata negli anni Cinquanta con il boom economico. E’ quello anche il dopoguerra degli Sciuscià, delle Segnorine a Napoli e degli episodi drammatici di violenza: saccheggi, stupri, brutalità, commessi da soldati alleati, soprattutto nel basso Lazio. Napoli, grande, seppure decaduta, capitale europea, è il teatro degli avvenimenti più significatici dell’altro dopoguerra, di una realtà che lo scrittore Curzio Malaparte in La pelle - con riferimento al degrado morale, tanto diffuso nella città partenopea - definisce come una peste che “non corrompeva il corpo ma l’anima”.
Film e romanzi, che saranno girati e scritti dopo, non supereranno mai la realtà viva, fatta di bambini che battono spazzole sulle cassette di legno, urlando sciuscià (storpiatura dell’inglese shoe-shine, che significa lustrare le scarpe) e di donne che per mantenere figli e famiglia sono costrette ad “arrangiarsi”.
Giorni drammatici, si vivranno quando gli Alleati arrivano alle porte di Roma e le popolazioni di quelle zone vivranno un’esperienza di liberazione traumatica, macchiata da infamie e misfatti criminali, da parte di reparti delle truppe francesi composte da soldati algerini, tunisini, senegalesi, camerunensi e marocchine, che si rendono responsabili di furti, rapine, omicidi, saccheggi e soprattutto stupri.
Queste scelleratezze, vili, avranno una rappresentazione letteraria esemplare nel romanzo La Ciociara di Alberto Moravia, e poi cinematografica, col film di Vittorio De Sica, con protagonista Sophia Loren.
Un fine guerra da incubo, in questo caso, rappresentato nel libro di Avagliano e Palmieri, in cui la gioia della liberazione, dopo la strategia del terrore nazista, è diventata una pagina buia.
In un documento, inviato al capo del Governo Badoglio, dalle autorità locali si legge: “Le popolazioni sfollate nei boschi corrono incontro ai soldati francesi convinte di incontrare i liberatori e invece trovano i marocchini che si sono precipitati su di noi come demoni scatenati, minacciando con le mitragliatrici bambine donne che poi hanno violentato”.
L’arrivo degli Alleati al Sud, non porta, dunque, solo cibo e risorse per la ricostruzione, e nuovi stimoli, tendenze, mode e culture, ma pure drammatici episodi che renderanno più difficile il ritorno alla pace e alla libertà, in regioni che già soffrivano la loro condizione secolare di abbandono ed emarginazione.
Non sono tutte luci, le storie dell’altro dopoguerra del Mezzogiorno.
Resta, indubbiamente, il vantaggio della liberazione anticipata, rispetto al resto del Paese, il primato di una restituita libertà. Non sappiamo valutare, a distanza di settant’anni, se è poco o molto, ma in realtà il Sud, nonostante la libertà, conquistata in anticipo, visse la sua liberazione con tutti i problemi drammatici, generati dal fascismo, e prima ancora dai vari governi, sempre indifferenti alle sorti di metà del Paese.
Problemi che si aggraveranno, più tardi, col ritorno della storica frattura Nord Sud e della mai risolta “questione meridionale”.
C’è, invece, un filo rosso che lega gli episodi di lotta ai tedeschi al Sud, col Nord dei partigiani, tanto da rappresentare, “questo Mezzogiorno”, un vero laboratorio per la Resistenza italiana.
In più, come viene fuori in ritardo, dagli archivi e dalle ricerche, sono stati migliaia i meridionali che militarono nella bande partigiane sulle Alpi e sugli Appennini, o all’estero o perché immigrati nel Centro Nord o perché militari di stanza in territori fuori dell’Italia liberata.
Non aver accomunato il movimento partigiano del Nord, agli episodi di resistenza spontanea al Sud, è un buco nero nella storiografia ufficiale: un errore, ammesso a distanza di anni, da Vittorio Foa, uno degli uomini simbolo della Resistenza italiana: “Io, da nordista, pensavo che nell’esperienza settentrionale ci fossero dei valori specifici superiori. Era una stupidaggine”.
Questa lacuna storiografica sull’altro dopoguerra meridionale, la colma ora un libro ben scritto e rigorosamente documentato: “Paisà, Sciuscià e Segnorine”, autori Mario Avagliano e Marco Palmieri (il Mulino, pagine 503, euro 26). E’ un saggio storico che ricompone il lungo racconto corale di quell’Italia che per prima si affacciò al dopoguerra, con lo sbarco in Sicilia (il 10 luglio 1943) delle truppe alleate salpate dall’Africa settentrionale e da Malta e successivamente con la risalita dello stivale italico.
Pochi giorni dopo lo sbarco in Sicilia, il 25 luglio, ci sarebbe stata la caduta di Mussolini.
Il percorso di uscita dalla guerra, dell’Italia, cominciò da Sud, con un dopoguerra diverso dal Nord e poco raccontato. Dal punto di vista sociale, il dopoguerra anticipato, del Sud e di Roma, costituisce anche un primo assaggio di quell’american way of life che si sarebbe poi affermata negli anni Cinquanta con il boom economico. E’ quello anche il dopoguerra degli Sciuscià, delle Segnorine a Napoli e degli episodi drammatici di violenza: saccheggi, stupri, brutalità, commessi da soldati alleati, soprattutto nel basso Lazio. Napoli, grande, seppure decaduta, capitale europea, è il teatro degli avvenimenti più significatici dell’altro dopoguerra, di una realtà che lo scrittore Curzio Malaparte in La pelle - con riferimento al degrado morale, tanto diffuso nella città partenopea - definisce come una peste che “non corrompeva il corpo ma l’anima”.
Film e romanzi, che saranno girati e scritti dopo, non supereranno mai la realtà viva, fatta di bambini che battono spazzole sulle cassette di legno, urlando sciuscià (storpiatura dell’inglese shoe-shine, che significa lustrare le scarpe) e di donne che per mantenere figli e famiglia sono costrette ad “arrangiarsi”.
Giorni drammatici, si vivranno quando gli Alleati arrivano alle porte di Roma e le popolazioni di quelle zone vivranno un’esperienza di liberazione traumatica, macchiata da infamie e misfatti criminali, da parte di reparti delle truppe francesi composte da soldati algerini, tunisini, senegalesi, camerunensi e marocchine, che si rendono responsabili di furti, rapine, omicidi, saccheggi e soprattutto stupri.
Queste scelleratezze, vili, avranno una rappresentazione letteraria esemplare nel romanzo La Ciociara di Alberto Moravia, e poi cinematografica, col film di Vittorio De Sica, con protagonista Sophia Loren.
Un fine guerra da incubo, in questo caso, rappresentato nel libro di Avagliano e Palmieri, in cui la gioia della liberazione, dopo la strategia del terrore nazista, è diventata una pagina buia.
In un documento, inviato al capo del Governo Badoglio, dalle autorità locali si legge: “Le popolazioni sfollate nei boschi corrono incontro ai soldati francesi convinte di incontrare i liberatori e invece trovano i marocchini che si sono precipitati su di noi come demoni scatenati, minacciando con le mitragliatrici bambine donne che poi hanno violentato”.
L’arrivo degli Alleati al Sud, non porta, dunque, solo cibo e risorse per la ricostruzione, e nuovi stimoli, tendenze, mode e culture, ma pure drammatici episodi che renderanno più difficile il ritorno alla pace e alla libertà, in regioni che già soffrivano la loro condizione secolare di abbandono ed emarginazione.
Non sono tutte luci, le storie dell’altro dopoguerra del Mezzogiorno.
Resta, indubbiamente, il vantaggio della liberazione anticipata, rispetto al resto del Paese, il primato di una restituita libertà. Non sappiamo valutare, a distanza di settant’anni, se è poco o molto, ma in realtà il Sud, nonostante la libertà, conquistata in anticipo, visse la sua liberazione con tutti i problemi drammatici, generati dal fascismo, e prima ancora dai vari governi, sempre indifferenti alle sorti di metà del Paese.
Problemi che si aggraveranno, più tardi, col ritorno della storica frattura Nord Sud e della mai risolta “questione meridionale”.