
Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
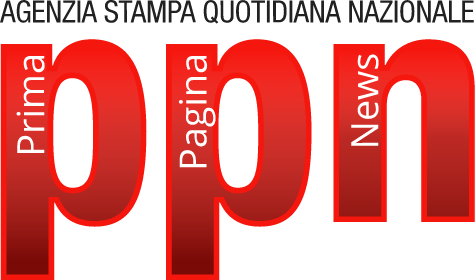
Al Centro Culturale Candiani dal 30 ottobre 2025 al 1 marzo 2026.

Al Centro Culturale Candiani dal 30 ottobre 2025 al 1 marzo 2026.
Edvard Munch, oltre Munch. Una mostra per raccontare l’uomo del suo tempo, che vive e lascia un segno nella società. Introspettivo certo, ma anche partecipativo; solo, nella sua inquietudine, ma non isolato; tanti i suoi legami con autori, artisti, letterati contemporanei – Ibsen fra tutti, di cui illustra le opere teatrali – che concorrono alla formazione del suo pensiero, alla sua rivoluzione grafica e iconografica, la sua vita. Munch è specchio della cultura mitteleuropea e cittadino del mondo; tra i lunghi viaggi e soggiorni a Parigi, in Germania, in Belgio, in Italia, in una Europa esplosiva, quella del Salon des Refusées, dei Secessionisti, i giovani ribelli; qui raccoglie echi antichi di Goya e Rembrandt, Redon e Toulouse-Lautrec, fino a Van Gogh e Gauguin, le influenze del Simbolismo e Postimpressionismo per poi lasciare il suo inconfondibile segno.
E poi, le nuove sonorità pittoriche, lo spirito nordico che entra in Europa e influenza le secessioni di Monaco, Vienna, Berlino, di cui Munch è protagonista.
Munch è il suo tempo, ed è il nostro. Perché quell’urlo espressionista che nasce dal corpo e rende l’arte totalizzante, carica di dolore, memoria, denuncia, non si è mai esaurito.
La nuova mostra ideata da Fondazione Musei Civici per il Centro Culturale Candiani – eccezionalmente ospitata nelle sale espositive del terzo piano – prende Munch come guida di una nuova avventura di scoperta dell’arte del nostro tempo, in un viaggio attraverso le collezioni civiche della Galleria Internazionale d’Arte Moderna – dove sono conservate quattro opere grafiche Edvard Munch Angoscia, L’urna, La fanciulla e la morte, Ceneri – nel segno della rivoluzione espressionista. Un progetto per riconnetterlo sia con le correnti artistiche dalle quali è partito sia con quelle che lui ha ispirato nei decenni successivi.
Le sette sezioni della mostra, partono quindi proprio da Edvard Munch (Loten 1863 – Oslo 1944), al confronto con i fermenti naturalisti, impressionisti e con il connazionale, meno noto, Aksel Waldemar Johannessen (Kongsvinger, 1880 — Oslo, 1922): una vicenda artistica intensa e breve, con Munch condivide la ricerca di mondo interiore tormentato, ma affronta la realtà con un realismo sociale che si carica di tensione espressiva, distante dall’estetica francese che domina l’arte norvegese del tempo.
Due i capitoli sulle Secessioni, le rotture artistiche dell’area tedesca che partono da Monaco nel 1892 e che proseguono poi con Vienna, nel 1897 e Berlino, nel 1898. L’eredità di Munch, con il suo segno vibrante e la tensione psicologica, permea questo clima, dei laboratori fertili, dove Simbolismo, Jugendstil e Postimpressionismo si intrecciarono in uno spirito di profondo rinnovamento.
La Secessione di Monaco include artisti come Franz von Stuck, interprete di un simbolismo visionario e sensuale ma anche molti artisti italiani, tra cui Arturo Martini e Alberto Martini, che qui trovarono stimoli decisivi per la loro arte.
Della Secessione di Berlino, Munch è quasi il casus belli; nel novembre 1892 la critica tedesca tradizionalista stronca le opere di Edvard Munch esposte Verein Bildender Künstler di Berlino. La mostra viene chiusa dopo appena una settimana, le polemiche non fanno altro che rendere celebre il nome di Munch in tutta la Germania, acuendo la frattura tra gli ambienti accademici e i giovani artisti della città. Pochi anni dopo, nel 1898 scaturisce la Secessione di Berlino, movimento che vedrà Munch protagonista. In questo periodo di forte fermento culturale, la ricerca di una nuova estetica si manifesta nei lavori di artisti come Liebermann, Klinger, Dettmann, Egger-Lienz, testimoni di una Berlino attiva, cosmopolita, protesa verso la modernità.
Superando le premesse impressioniste, Munch guarda al Simbolismo, all’opera di Redon, Sérusier, Bonnard, alla produzione di Klinger e ai dipinti di Böcklin che lo avvicinano a un linguaggio simbolista, permeato di immagini allusive e visionarie, di sogni, interiorità e mistero. In Belgio, la corrente assume importanza grazie ad autori come Félicien Rops – legato agli ambienti letterari decadenti parigini e influenzato da Baudelaire, Mallarmé e Verlaine – e James Ensor, inventore di un mondo grottesco popolato da maschere, scheletri e figure mostruose, sviluppando un simbolismo fantastico e a tratti caricaturale, ricco di satira sociale.
E ancora, il confronto con il Simbolismo in Italia che assume declinazioni diverse e originali, tra le sculture intense e drammatiche di Adolfo Wildt, gli scenari cupi e opprimenti di Cesare Laurenti, lo spirito ribelle di Ugo Valeri.
L’ampia rappresentazione di opere grafiche in mostra racconta il debito dell’Espressionismo tedesco al segno di Edvard Munch, la cui influenza, soprattutto nella grafica, è fondamentale per il gruppo Die Brücke. Artisti come Erich Heckel riscoprono la xilografia e le tecniche incisorie come mezzo diretto, essenziale, primitivo, ispirandosi tanto alla tradizione di Dürer quanto alle tecniche innovative del maestro norvegese. Dopo la guerra, una seconda generazione – tra cui si distinguono Otto Dix e Max Beckmann – traduce il trauma collettivo in immagini più crude e disilluse. Nella grafica, la figura umana è scavata fino all’osso: non più solo un grido individuale, ma il riflesso di una società lacerata.
Ne L’urlo contemporaneo riverbera la lezione di Munch e le ricadute nella sensibilità degli autori del Novecento. Dopo la Seconda guerra mondiale, le istanze dell’Espressionismo si rintracciano nelle testimonianze degli orrori vissuti in prima persona: Renato Guttuso racconta la brutalità della storia, mentre Zoran Musič non smette di evocare l’esperienza indicibile dei campi di concentramento. L’urlo espressionista si ritrova nelle visioni deformate e mostruose della Maternità di Ennio Finzi o nelle Figure alterate di Emilio Vedova. Gli orrori dell’attualità sono nei teschi di Mike Nelson, e i mondi popolati da mostri e maschere di Brad Kahlhamer e Tony Oursler. Il grido di dolore risuona nella tragedia della guerra di Jugoslavia, di cui Marina Abramović si fa interprete, e si ritrova, infine, nella denuncia appassionata e drammatica di Shirin Neshat, incisa sulla pelle e sul destino del popolo iraniano.
“Munch. La rivoluzione espressionista” segna l’ultimo capitolo di una rassegna che, partendo da capolavori delle collezioni di Ca’ Pesaro dei maestri dell’arte moderna e contemporanea, ne racconta le contaminazioni, le prossimità, il proprio tempo, le vicende artistiche e soprattutto, l’eredità contemporanea attraverso il Novecento, fino ai nostri giorni. L’attesa è anche per il nuovo Centro Culturale Candiani, ridisegnato da MUVE che, oltre a proseguire nel programma di esposizioni temporanee, diventerà un Museo permanente, una Casa delle Contemporaneità.
La collezione della nuova sede MUVE sarà dedicata alla voce contemporanea, con opere di Maestri italiani e internazionali dal 1948 in poi, articolate in un percorso inedito e di ampio respiro.
 APPUNTAMENTI IN AGENDA
APPUNTAMENTI IN AGENDA